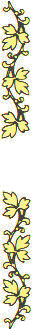 |
La vita quotidiana della popolazione di Agropoli nel XVIII secolo
offre un modello di equilibri di autoassistenza molto esigui. Abitata principalmente
da pescatori, marinai, contadini, in prevalenza piccoli affittuari, lavoratori
a giornata e gualani che vivevano poco al di sopra della miseria. Anche
l'agricoltura era ad un livello di pura sussistenza, talora di precarietà,
sul quale si elevava di poco qualche famiglia di massaro e di benestante.
Al di sopra di tutti spiccano gli ecclesiastici e la figura del feudatario.
Nobiltà e clero accentravano nelle propia mani, oltre al potere
politico, la maggior parte delle ricchezze. Agropoli, come tutte le piccole
comunità del Cilento, viveva una sua storia scandita da una temporalità
molto lenta, tra il lavoro, la pratica religiosa, l'intimità della
famiglia. La civiltà materiale era regolata da rigide leggi: dominante
era la consuetudine, a cui si faceva riferimento per la risoluzione di
ogni problema. La Chiesa aveva un dominio incontrastato sulla coscienza
individuale e sulla mentalità collettiva, angosciate dalla paura
dell'ignoto e dalle forme oscure del male. Tale sentimento si trasformava
in terrore difronte alle calamità naturali, alla peste, alle carestie.1
La vita di questa piccola comunità ruotava intorno alla parrocchia,
che si trovava al centro del paese e, sul sagrato della chiesa, la gente
si raccoglieva, dopo le funzioni religiose, nei giorni di festa, per tenere
pubbliche assemblee. Nei giorni di festa, ubbidendo ai precetti della Chiesa,
si tralasciava il lavoro per dedicarsi al culto ed al riposo. Le feste
erano numerose: nel 1642, il papa Urbano VIII ne fissò trentasei.
In pratica si cercava di tenere gli uomini il più lontano possibile
dalle osterie, dove spesso l'ubriachezza creava disordini e risse. L'osteria
era vista, quindi , come un luogo di peccato e di perdizione e ritenuta
l'antiparrocchia.2 Raramente un evento veniva a rompere la monotonia della
vita quotidiana: grande curiosità generava tutto quanto veniva da
fuori, come il Vescovo in visita pastorale, il nuovo feudatario, le missioni
popolari. Queste ultime erano molto richieste dal popolo e appena giungevano
in paese, la chiesa si affollava di gente desiderosa di ascoltare i predicatori
impressionati anche da una certa spettacolarità allora di moda tra
i missionari, fatta di teschi, penitenze, torce e ceri accesi. L'intero
paese accorreva alla pratica sacramentale e quando la missione era finita,
tutti conservavano per anni il ricordo di quell'evento.3 S. Alfonso dei
Liguori avvertì la necessità di tenere con maggiore frequenza
le missioni tra le popolazioni rurali. Compose nel 1733 "Il Regolamento
delle Missioni" per la Cogregazione degli Irredentisti, proponendosi
inoltre, di evangelizzare l'intero Cilento. Il progetto fu realizzato solo
in minima parte nel '700, perchè solo nel secolo successivo, gli
Irredentisti visitarono tutti i paesi del Cilento.
|
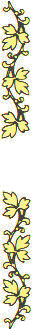 |