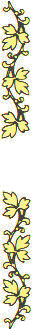 |
Nel 1754 venne compilato ad Agropoli il "Catasto Onciario"
da 8 deputati, che furono eletti il 10 marzo 1753 in "pubblico parlamento"
dai Magnifici, eletti al "Reggimento dell'Università della
città di Agropoli"7. Riguardo a ciò bisogna riferire
che il Concordato del 1741 stipulato tra Carlo III ed il Pontefice stabiliva
il diritto dei Vescovi ad intervenire , sia direttamente che indirettamente,
alla formazione dei catasti.8 In tale concordato, la Cancelleria vescovile
di Capaccio, il 28 novembre 1752, indicò come deputati ecclesiastici
per la compilazione del catasto di Agropoli il Rev/do Andrea Ventrella,
Parroco del paese, ed il Padre Guardiano di San Francesco dei PP. Conventuali
di Agropoli, senza però indicarne il nome, non risultando neanche
nelle pagine ingiallite del Catasto. Insieme ad essi, operarono anche i
Signori: Gregorio Troisi, Onofrio Taddeo, Francesco Casalicchio, tale Vetta
(non comprensibile il pronome), Aniello Palomenta e Giuseppe Cavallo. Il
Catasto si presenta formato da due grossi volumi di cui uno costituisce
gli "Atti preliminari" l'altro quello delle "Rivele"
In esso sono registrati i contribuenti oltre ai membri delle singole famiglie.
Oltre ad essere iscritti i cittadini che formano "i fuochi" del
comune, sono riportati in un elenco a parte tutti i forestieri che vi hanno
la residenza o che vi posseggono beni. Un'altra importante distinzione
viene fatta tra i laici e gli ecclesiastici: quest'ultime comprendono anche
gli Enti e le Istituzioni religiose. I contribuenti sono divisi per categorie
e riportati in elenchi diversi. I cittadini residenti devono pagare il
"testatico" (solo i capifuoco); un'imposta sul reddito da lavoro
(solo i maschi), e la tassa sui beni. Sono esenti dal "testatico"
chi "vive del suo" e i nobili. Le vedove e le vergini sono accatastate
in elenchi separati se costituiscono i capifuoco. Esse sono esente dal
testatico e dell'imposta sul lavoro, sono, invece, tenute a pagare la tassa
sui beni se il reddito supera i sei ducati. Gli ecclesiastici secolari
cittadini, costituiscono una categoria a parte, perchè, della loro
rendita, viene riportata quella parte che non rientra nei limiti fissati
dalla Diocesi, entro cui il patrimonio sacro è esente da tasse.
I forestieri abitanti laici, sono tenuti al pagamento della tassa sui beni
ed un "jus Habitazionis" di 15 Carlini. In questo elenco è
iscritto il feudatario Delli Monti Sanfelice Girolamo. I forestieri non
abitanti laici, devono pagare la tassa sui beni che possiedono nella città
(sono iscritti con il nome di "bonatenenti"). La distinzione
tra forestieri e residenti risponde anche ad un'altro presupposto, che
cioè i cittadini sono tenuti a pagare i contributi comunali, che
sono di 54 carlini , oltre i 192 carlini per ogni fuoco, necessari a coprire
le spese locali; mentre i forestieri ne erano esenti perchè non
hanno alcun vantaggio diretto dai servizi locali. Naturalmente i forestieri
abitanti, godendo dei benefici dei servizi comunali, devono pagare lo "jus
Habitazionis" Un'altra distinzione che risulta è tra i contribuenti
che "vivono del propio" ed esercitano professioni nobili e quelli
che invece vendono il propio lavoro (i bracciali) e coloro che esercitano
i lavori manuali che sono tenuti a pagare non solo la tassa sul salario
ma anche il "testatico". I beni denunciati dai contribuenti sono
i beni immobili. Essi sono territori, case, vigne, molini ed anche animali.
Su quest'ultimi però il reddito imponibile si riduce del 50% su
quello dichiarato perchè essi sono soggetti alla mortalità.
La rendita dei beni è espressa in ducati e carlini, per poi essere
tradotta in once.
|
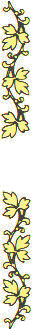 |
